Lì dove il male germoglia e crea odio e violenza
Una riflessione di Serena Fierro sull'odio che si insinua in tutti noi ed esplode in violenza
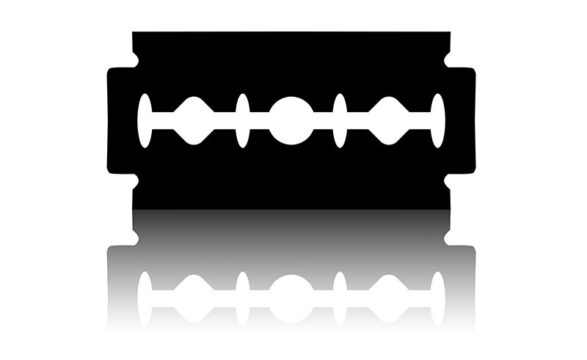
Lì dove il male germoglia e crea odio e violenza( di Serena Fierro). È lì, silente, eppure reale. S’insinua sempre più lentamente: dapprima, lontano dalla vista e dallo sguardo; poi esplode, immancabilmente, quand’è ormai troppo tardi. E in un colore, puntualmente, rosso sangue.
È lì, alla fermata del bus, o all’angolo della strada; entro i corridoi di scuola, oppure tra banchi innocenti. Lì, seduto ad aspettare, il suono della campanella o due spalle voltate. Quasi fischi d’inizio d’una sempre irrefrenabile, inarrestabile corsa verso l’inferno. E sempre più spesso, in un omertoso, compiacente silenzio.
È lì, nel cuore delle città metropolitane, non meno che delle periferie dimenticate. Nei quartieri un tempo tranquilli, non meno che tra le pagine d’un social network. Dinanzi alle porte degli stadi, travestito da credo sportivo; non meno che tra gli slogan pubblicitari, vestito da atto di protesta. Di sensibilizzazione. Liberazione.
Ovunque volgiamo lo sguardo, sembra ordunque di assistere, oggigiorno, ad un’epidemia destinata a spalancarsi sempre più profonda: un’esplosione, in apparenza inarrestabile, di inaudita, efferata violenza. Un male diffuso, un trasversale disagio, teso a raggiungere di sempre nuove, aberranti forme di crudeltà.
Giovani, sempre più giovani, e sempre più protagonisti di atti di aggressione; di vandalismo; di bullismo. Adulti, e sempre più adulti, responsabili di crimini di sempre maggior indiscussa, indiscriminata ferocia. Complice, nondimeno, finanche ormai la rete, teatro e coacervo insieme di pubbliche umiliazioni. Circuito morboso di visibilità e compiacenza. Di pubblico plauso e pubblica gogna.
“Perdita di punti di riferimento”. “Assenza di modelli positivi”. “Difficoltà a comunicare emozioni in modo sano”: solo alcune delle espressioni, più trite e ritrite, in uso da parte di sociologi, psicologi, antropologi di turno.
Nel tentativo, spesso maldestro, di denunciare, o forse spiegare, finanche a se stessi, soltanto l’ultimo, più esteriore sintomo d’un disagio ormai tutto emotivo, psicologico; educativo, relazionale. Esistenziale. E nondimeno, spia della degenerazione d’una società intera.
Una società in cui, sempre più spesso, si tende ad identificare il “male” con un nemico proveniente esclusivamente dall’esterno. Un avversario; uno straniero; chiunque – o qualunque cosa – sia al di fuori di noi. E a noi non appartenga.
Una società in cui finanche ogni emozione, sentimento, avvenimento, accadimento, sembrano essere divenuti ormai legittimo pretesto ed alibi insieme tramite cui sfogare, giustificare o condonare i propri più sopiti, repressi istinti.
Una società in cui la costruzione del “nemico” sembra essere pratica ormai consueta, passando direttamente per la porta di casa nostra: dal linguaggio politico alla comunicazione pubblica; dai rapporti sociali ed interpersonali non meno che privati e familiari.
Una società in cui esiste, in definitiva, sempre qualcuno da accusare; da biasimare, da condannare. E sempre un “altro” contro cui scagliare, indubitabilmente, la colpa.
Eppure, proprio filosofia e psicologia da sempre c’insegnano che, sovente, siffatto male altro non è che, a ben vedere, riflesso e specchio d’un meccanismo tutto interiore: quel disperato tentativo d’espellere ciò che non accettiamo di noi, e dentro di noi.
Sia pur con l’inevitabile, ovvia conseguenza di proiettarlo in automatico sulle altrui esistenze. Quel nostro “peggio” – che sia per rabbia, per paura, fragilità, frustrazione – che finisce immancabilmente per assumere, allora, il volto dell’altro.
Un altro, puntualmente, trasformato in colpevole, acerrimo nemico; in ostacolo da esecrare, eliminare ad ogni costo, secondo un’altrettanto antica, primordiale, e pur tuttavia non meno distruttiva, legge non scritta. Liddove, anziché guardare dentro, si sceglie la via sovente preferenziale, più facile e meno ardua: quella dell’accusa. Quella della colpa.
Una scelta, pur tuttavia, che non ci libera e non redime; che ci tiene, all’opposto, tutti ostaggi e tutti vittime d’un perenne, insanabile conflitto. Con l’altro, non meno che con noi stessi.
E allora, talvolta triste, amara verità è che non sempre il male ha radici così radicali, estreme. Non sempre possiede profondità, dimensioni demoniache: al contrario, possiede spesso un volto ordinario.
E può benissimo invadere e devastare un mondo intero proprio quanto una metastasi in superficie: per mero, superficiale, banale contagio. Esattamente quel “banale che seduce e distrugge” come, non molti anni addietro, scriveva la stessa Hannah Arendt nella sua omonima opera capitale.
Talvolta, allora, è forse soltanto nell’immaginario collettivo che il male assurge ancora a qualcosa di romantico, di vario; mentre invero, più prosaicamente e più tristemente, il male reale è assai più cupo, monotono. Desolante.
Talvolta, allora, converrebbe forse non indulgere, non lasciarsi sedurre o ingannare da apologhi estetizzanti; da rappresentazioni puramente grandiose, titaniche del male; bensì, riconoscerne tutta la nostra banale, quotidiana responsabilità. Quella fatta di omissioni, d’indifferenza; di spalle voltate. Di egoismi ripetuti, di errori maldestramente reiterati.
Un cammino alternativo, sia pur forse faticoso, ma necessario, è allora certamente possibile: riconoscere il male che ivi ci abita. Non per giustificarlo, non per condonarlo; bensì, per accoglierlo come parte integrante della nostra umana fragilità. Per poi, finalmente poi, trasformarlo.
Perché forse, il male non s’annienta e non s’arresta esperendolo, espellendolo al di fuori di sé. S’attraversa, si trasfigura. In un processo in apparenza oneroso – forse a tratti impossibile – ma pur tuttavia tale da restituirci alla nostra stessa umanità; tale da liberarci dall’ostinazione a voler trovare sempre, indistintamente, un nemico contro cui scagliarsi.
E perché, forse, la via sapienziale è allora guardarsi in volto, senza illusioni; riconoscere che il confine tra bene e male attraversa sempre, inevitabilmente, ogni cuore umano; e rientrare, alfine, in noi stessi. Giacché solo chi conosce – e riconosce – la propria ombra può altresì imparare a non proiettarla all’esterno. Sull’altro.
“Che cara cosa è l’essere umano, quando è umano”, scriveva Menandro, antico commediografo greco, circa duemila anni fa. Un verso, un monito che, a distanza di secoli, conserva ancora intatta la sua perdurante attualità.
Perché essere umani non è solo questione di nascita, d’appartenenza; bensì, di comportamento. Perché la vera essenza dell’uomo si rivela quando agisce con gentilezza; con giustizia; con empatia: quando la sua umanità non è solo mero dato biologico, bensì consapevole scelta.
Perché la bellezza dell’essere umano, come siffatta tradizione di pensiero – da Menandro ad Harendt – cerca ancor oggi di suggerirci, non risiede in ciò che egli possiede; nel potere che detiene; nelle capacità che dimostra. Bensì, nel suo modo di relazionarsi agli altri. Con l’altro.
Sicché è forse qui, proprio qui, allora, la sfida più grande che a ciascuno di noi oggi arride: ricordarci, ogni giorno, cosa significhi davvero essere umani. Non per abitudine, non per convenienza, non per legge. E neppure per dovere: religioso, politico, legale, etico o morale che sia. Bensì, per pura, autentica scelta.
Perché allora, e soltanto allora, come scrive Menandro, l’essere umano diventa davvero umano. Diventa davvero cosa preziosa.
E perché, parimenti, allora e soltanto allora, quel male in apparenza sì grande, sì illimitato – eppure, in definitiva, così “banale” – diventa finalmente, e per davvero, qualcosa d’ “altro”. Qualcosa di finalmente avulso, lontano, “fuori” da noi.