Moiano: la via del me stesso
Una strada da intitolare a Tommaso Giaquinto e Umberto Bile
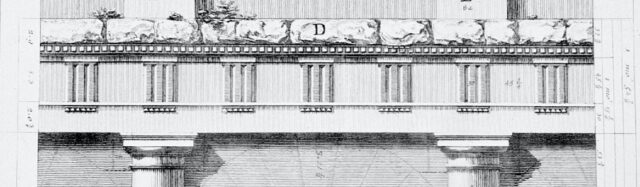
Moiano: la via del me stesso ( di Giacomo Porrino )
Lo studio dei nomi dei luoghi è fondamentalmente un atto di umiltà. Ed è il contrario di quanto solitamente viene percepito in relazione alle attività di una commissione toponomastica.
Spesso il commissario avverte un malcelato senso del potere riferito alla potestà demiurgica di imporre un nome a una strada o a un luogo. si tratta di una fenomenologia diffusa e addirittura comprensibile, per quanto da rigettare senza esitazione.
La materia toponìmica implica considerazioni di una grande complessità che non lasciano spazio a improvvisatori e improvvisazioni. Ciò è tanto più vero quanto sterminate sono le commissioni toponomastiche – e odonomastiche – che popolano le amministrazioni comunali italiane.
E anche a Moiano non sono mancate, nel corso del tempo infatti m’è accaduto di contarne più d’una.
Quel che ha sempre connotato virtuosamente queste commissioni è stato proprio il non decidere alcunché. Una grande fortuna, in effetti, se si pensa ai disastri che ne sarebbero derivati in termini di dilettantismo e autoreferenzialità.
Tranne il caso della cosiddetta piazza intitolata a «Giovanni Paolo II grande», titolazione perlomeno frettolosa, peraltro mai esistita in carico al santo di Cracovia, e il cambio della Via Sannita in Via Santa Maria di Moiano dopo le celebrazioni del centenario della Incoronazione nel 2014, non sono state registrate attività degne di nota.
La toponomastica, con la sempre trascurata odonomastica, è una materia affascinante ma insidiosa. Perché ci porta a considerare accessibili scelte e ragioni che spesso non sono alla portata di molti, anche se lo sembrano.
È uno straordinario baule di preziosità storiche e memoriali di qualunque comunità. È un silenzioso archivio di indicazioni e tracce di storia dislocate nel quotidiano. Non a caso, quasi sempre, un toponimo è l’unico documento istantaneo, icastico, dialogante di un sentimento collettivo cui però se ne ignorano le origini.
E come avvertiva un celebre glottologo, la toponomastica «vive a monte e a valle della narrazione storica, la nutre e se ne nutre. Non è materia per dilettanti, e tra le insidie da cui deve guardarsi sono proprio i malintesi e le trascrizioni arbitrarie».
Ora, una prospettiva coerentemente volta al recupero di questa complessità silenziosa, di questo insieme di nomi sempre letti e quasi mai pronunciati, implicherebbe una rigorosa struttura conoscitiva che permetta quelle necessarie opere di recupero filologico del patrimonio toponìmico locale insieme alla ricerca di titolazioni nuove che segnino però correttamente gerarchie di senso compiute e non relegate al mero impressionismo gratuito.
Che, detto vulgariter loquendo, significa evitare il rischio di imporre nomi di strade e piazze a vanvera, inseguendo tentazioni celebrative e autocelebrative mosse da cortigianerie insulse e lesive della storia dei luoghi.
Ma qui sta il problema non marginale. Come prendere eventuali decisioni in merito ai nomi dei luoghi se si ignora la storia di quegli stessi luoghi? La domanda non è affatto peregrina e tende a ricordare come i nomi delle parti delle nostre città non rispondano alle prurigini o alle insensatezze del momento, ma sperabilmente a uno studio rigoroso fondato su chiari criteri metodologici.
Nel caso di Moiano, avendo saputo dell’insediamento di una nuova commissione toponomastica, cui rivolgo non pochi auspici di buon lavoro, mi sento di indicare due diverse direzioni che a mio avviso dovrebbero segnare il suo operato.
Il recupero filologico del patrimonio topo-odonomastico storico insieme a una meditata scelta delle nuove titolazioni. Ricordando sempre come ogni nuovo nome di una strada va ineludibilmente a intersecarsi con un nome che ha una provenienza incardinata nella storia.
Nell’ultimo venticinquennio del XIX secolo, a Moiano come altrove, la borghesia del ceto economico dominante, ormai padrona delle leve del nuovo potere politico, avverte l’esigenza inderogabile di imprimere arbitrariamente l’ideologia del nuovo status attraverso la negazione di tutto quanto, della storia, era percepito come un inutile e ormai poco confacente arnese cui vergognarsi e da emendare.
È in quel momento che odònimi secolari come per esempio Cannavale, Tramonti, Piazza, diventano improvvisamente Via del Progresso, Via Ciardulli, Via del Commercio. Si direbbe una operazione di riscrittura del marketing sociale in vista di quella che voleva chiaramente porsi come la costruzione di una nuova forma della comunità. Una forma scelta da pochi per molti, beninteso.
Recuperare un toponimo è una forma di restauro che trova nel recupero del frammento perduto di un nome il recupero di un valore solo dimenticato, mai in ogni caso perduto. Recuperare per esempio Via del Pontone in luogo di improbabili vie di papa e papi, avrebbe un valore senza dubbio importante.
Recuperare Piazza delle Botteghelle o Piazza di Santa Maria dei Liberi o, ancora, la Corte delli Paoli e la Corte Juliana sarebbe indubitabilmente un prezioso cantiere di scavo archeologico nella memoria di una comunità.
Ma, ancora una volta, che cosa sono e dove si trovano questi nomi? A quali ,luoghi si riferiscono e quali modificazioni hanno variamente manifestato nel corso del tempo? Giusto per rammentare la complessità della faccenda. Giusto per far presente, bisbigliandolo, che non si tratta di temi lievi da affrontare con il piglio sereno di un après-midi tra vecchi amici.
E per quanto concerne le nuove titolazioni, a Moiano e Airola non mancano certo le ipotesi di lavoro plausibili e fondate nella storia. Tommaso Giaquinto, Carlo D’Adamo, Luigi Vanvitelli, Domenico Brunelli, Giambattista Antonini, Ferdinando Colonna, Francesco de Mura, Felice Barilla, sono frammenti di storia e storie profondamente innervati nella storie di queste terre. E sarebbe non rimandabile individuare finalmente una loro collocazione adeguata seguendo un solido principio di priorità in ordine alla loro importanza.
Stesso discorso per la storia più vicina a quella del nostro presente. Vincenzo De Crescenzo e Umberto Bile sono le proiezioni di una storia che giunge fino a noi e che, ognuno segnato dalla propria diversità, aiuterebbe chi vive il presente storico – gli attuali avventori delle strade locali – a chiedersi che cosa ci faccia un nome inchiodato su un muro. Da che cosa venga quella storia che oggi ci serve per orientarci nello spazio, per darsi convegno, per indicare un riferimento.
in fondo è facile. Basterebbe, con uno sforzo tra l’olimpico e il sonnacchioso, tenere a mente che una commissione toponomastica non è chiamata a servire le ansie di rappresentazione di questo o quell’attore del potere del momento. Non serve ad affiggere nomi di parenti, amici e affini.
Men che meno ha la vocazione di vellicare la deriva, sempre in agguato, del culto della personalità. In questo senso, la «via a me stesso» sarebbe l’ennesimo indicatore del degrado irredimibile di una comunità sempre più ripiegata sulla propria mediocrità indolente e aggressiva.
Non inseguo illusioni, non mi affido alla speranza, non mi aspetto niente di diverso dal nulla. E tuttavia per le brevi ragioni esposte, la commissione toponomastica non può che avere i miei auguri. Molti auguri. Molti senza meno.