Piccola geografia dell’oblio. Monteoliveto ad Airola nel silenzio di un anno
Anche così muore un territorio
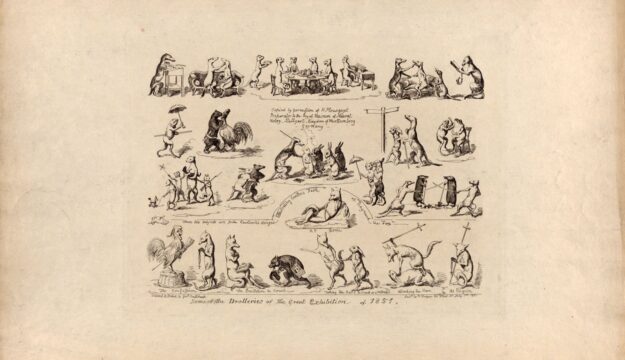
Piccola geografia dell’oblio. Monteoliveto ad Airola nel silenzio di un anno ( di Giacomo Porrino ) . Circa quindici anni or sono il Politecnico di MIlano ha promosso un progetto di ricerca sull’abbandono e lo spopolamento dei borghi in Italia nella prospettiva di nuove opzioni di pianificazione territoriale volte a impedire il depauperamento definitivo degli aggregati urbani storici e più esposti al fenomeno dello spopolamento.
Ma c’è una forma di abbandono, certo correlata, più insidiosa perché resa invisibile dalla trappola del silenzio e della banalizzazione della quotidianità. L’abbandono involontario, mai sancito e tuttavia ribadito, del proprio territorio culturale.
Che è un insieme complesso di visibile e invisibile, provenienze e permanenze, materialità e immaterialità, mutilazioni e rivelazioni, viltà e coraggio tutti incastonati nello stesso paesaggio storico.
In questa attuale vertigine delle dismissioni culturali, della rinuncia alla essenza di sé, della spettacolarizzazione del falso fabbricato per vellicare l’indifferenza dei cittadini, della fuga dal rischio e della fatica del conoscere, si osserva nitidamente l’atteggiamento arrendevole e rinunciatario alle spinte che tendono alla capillare diffusione di un impoverimento culturale sempre più pervasivo, sempre meno percepito.
Come vedere qualcuno privarsi di ogni vestito senza che neanche se ne renda conto. E se gli si chiede come mai lo faccia egli non saprà dare alcuna risposta, non saprà che infilarsi nella propria automobile, preferibilmente di grossa cilindrata, e con piglio seccato si dileguerà verso le formidabili certezze che prova a rimediare nel suo vissuto livido e annoiato.
Per quanti avessero qualche perplessità a riguardo, per le prurigini dei sagaci della domenica, mi permetto di suggerire un caso di scuola, emblematico e desolante. Più di un anno addietro è stato abbandonato il convento di San Gabriele a Monteoliveto in Airola.
Senza dilungarmi sul significato storico e culturale di una tale presenza per le comunità caudine, avendolo già segnalato in un mio articolo del tempo, forse è interessante notare tutto quel che è accaduto a distanza di oltre un anno dagli eventi. Cioè niente, ma non in sintesi. Proprio niente.
Tranne lo slancio iniziale della amministrazione comunale, che cercai di coinvolgere nella vicenda e della quale ignoro però gli esiti, nessun caudino, nessun airolese mi risulta abbia trovato lo spunto di una qualche idea per cercare di raccogliere i resti mortali di un grande passato e portarli, vivificati, dentro un presente una volta tanto virtuoso.
Già un anno fa mi chiedevo dove fossero, qualora ve ne fossero, le forze economiche locali, le quali insieme a quelle istituzionali avrebbero ben potuto ideare un piano plausibile. Eppure le potenzialità teoricamente interessanti non mancavano di certo, non mancherebbero neanche oggi a dir il vero.
Eppure s’è preferito consegnarsi al più confortevole caravanserraglio dei caroselli in costume, delle passerelle un tanto al chilo, delle mutue gratificazioni in forma di carezzevoli riconoscimenti e altre amenità inutilmente salmodianti.
Ma tutto questo attiene al verosimile, degenerando nelle logiche del falso. E se si sceglie il falso, poiché facilmente accessibile, ci si consegna alla inesistenza, alla irrilevanza, alla noia.
Nel mentre, i locali si concedono il lusso, degno della cultura di un emiro senza danaro, di ignorare un dipinto di grande importanza come quello di Giacomo del Po, oppure un sito ultramillenario dove, tra l’altro e malgrado tutti, permane ancora l’incredibile sopravvivenza di un luogo unico in tutto l’occidente europeo e per alcuni aspetti anche del vicino oriente antico.
Tutto questo sembra essere sparito dai radar dei caudini contemporanei. Non perché l’abbiano dimenticato, ma perché non l’hanno mai conosciuto. Perché la conoscenza costa, molto. E soprattutto non si può improvvisare, non si può comprare, non si può contrabbandare.
Ecco perché si preferisce l’inedia della rappresentazione, della verosimiglianza, del culturame come pastoia che avvelena silenziosamente quel che resta della coscienza riferita alle molte preziosità che spesso mostriamo di non meritare.
No, non è accaduto niente in questo primo anno di abbandono del tesoro di Monteoliveto. Ben per questo l’unico presidio da opporre alla sua definitiva sparizione è la conoscenza. Portare le persone a rendersi conto, opportunamente introdotte, di che cosa hanno già perduto come comunità locale. Di che cosa rischiano di perdere definitivamente come presenza culturale di rilievo.
Servirà? Senza cedere ad alcun sortilegio nella boscaglia delle illusioni, non lo penso probabile allo stato delle cose. Però servirà a mostrare le ipocrisie inescusabili di tutti quelli che portano in processione le parole, ormai intossicate, di «territorio», «identità», «memoria», come reliquiari del niente.
Perché il culturame è pestilenza non meno piagante di quella custodita nella lunga storia del convento di San Gabriele in Airola. Dove domattina avrò il piacere di incontrare chi vorrà esserci, spartendo insieme i motivi autentici per cui non arrendersi alla sorte dell’abbandono di un luogo che meriterebbe infine la nostra cura, il nostro interesse, il nostro amore.
Tornando magari alla ambizione di deragliare felicemente dai binari del nostro oblio.